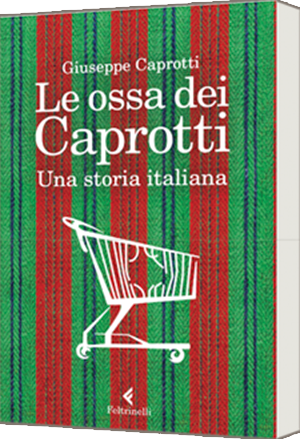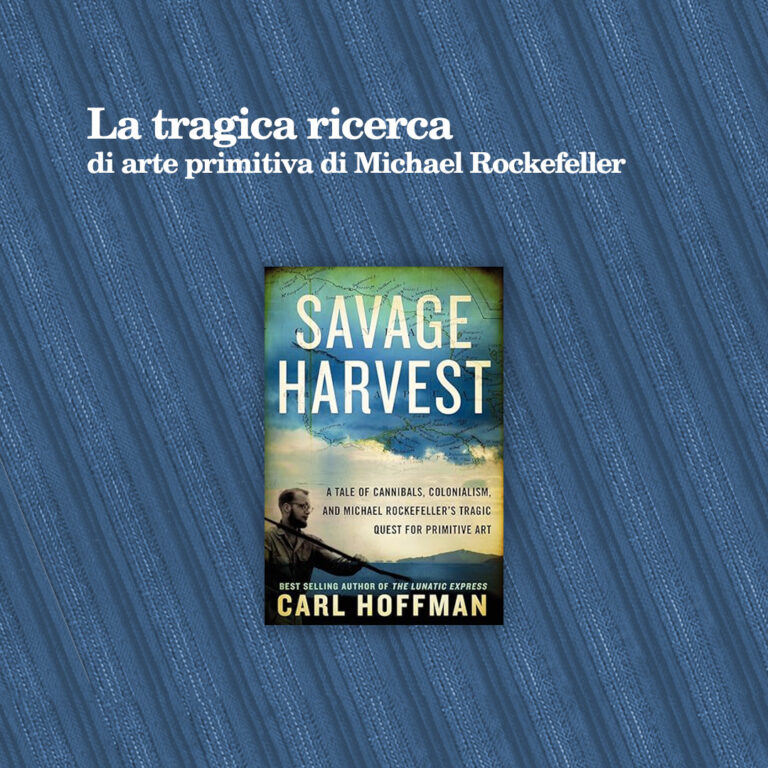L’amore di Nelson Rockefeller per l’arte, e in particolare per quella contemporanea, ha origine da sua madre, Abby Aldrich Rockefeller, che apprezza l’arte in ogni forma e la colleziona nella casa dove Nelson cresce; quando lui va a studiare all’Università di Dartmouth, gli concede un sussidio per poter coltivare la sua passione per il collezionismo in maniera indipendente, formandosi un suo proprio gusto. Come dice la figlia di Nelson, Mary Rockefeller Morgan, “mio padre è cresciuto guardando cose belle, e i suoi genitori erano molto consapevoli della sua capacità di vedere cose belle”. Abby Aldrich Rockefeller però crede profondamente anche nell’importanza di rendere l’arte accessibile al pubblico. Riconoscendo la necessità di un’istituzione che accolga quanto esula dai canoni classici, nel 1929 co-fonda con Nelson e altre co-fondatrici, Lillie P. Bliss e Mary Quinn Sullivan il Museum of Modern Art (MoMA), che a lungo dirige insieme al figlio. Ricordando la filosofia materna secondo cui l’arte rende più ricettivi, più attenti e comprensivi, Rockefeller attribuirà sempre a lei il merito di aver nutrito la sua creatività e il suo spirito attraverso l’arte.
Ispirato dalla madre e spinto dalla propria curiosità e creatività, Rockefeller si forma una collezione di opere provenienti da epoche e luoghi diversi. Nutre una particolare affinità per le opere dell’espressionismo astratto, un movimento artistico nato a New York dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma anche per Pablo Picasso e Jackson Pollock. Contemporaneamente, colleziona arte popolare del Nord e Centro America, sculture dell’Africa e del Sud-est asiatico, stampe giapponesi e porcellane dell’Europa del XVIII secolo. Verso la fine della sua vita, dopo che il movimento della pop art americana raggiunge il suo apice a metà degli anni ’60, commissiona ad Andy Warhol la creazione di ritratti di sua moglie e di se stesso.
Come la madre, Rockefeller forma la propria collezione d’arte ma crede pure nell’importanza di portare l’arte al pubblico. Abbiamo già visto la sua esperienza al MoMa; come governatore di New York, nel 1960 istituisce il NYSCA-New York State Council for the Arts, la prima agenzia governativa statale a fornire sussidi per le arti, modello per il National Endowment for the Arts, un’agenzia federale che offre supporto e fondi ai più promettenti progetti artistici, istituito tramite una legge del Congresso nel 1965.
Dopo la tragica scomparsa del suo quinto figlio, Michael Clark, durante una spedizione in Nuova Guinea, Rockefeller fonda il Museum of Primitive Art di New York, oggi riconosciuto come l’ala Michael C. Rockefeller del MoMa.
Michael C. Rockefeller: la tragica fine di un antropologo
Nel marzo del 1961, poco dopo essersi laureato ad Harvard in antropologia, il ventitreenne Michael intraprende un viaggio nella Guinea Olandese (oggi la parte più orientale dell’Indonesia) per girare un documentario e nel frattempo comprando oggetti per la collezione di arte primitiva di suo padre. Una mattina di novembre, il catamarano su cui naviga si ribalta, gli uomini a bordo vanno alla deriva per un giorno, poi Michael decide di nuotare a riva per cercare soccorso, e scompare. Nel 1964 viene dichiarato legalmente morto. La famiglia sostiene e sosterrà sempre la tesi dell’annegamento; ma un’altra tesi dice che il giovane incappa in una tribù cannibale che lo uccide e se ne ciba.
Dopo decenni di film, inchieste ed illazioni, il giornalista Carl Hoffmann scrive un libro che esce negli Stati Uniti nel 2014, Savage Harvest: A Tale of Cannibals, Colonialism, and Michael Rockefeller’s Tragic Quest for Primitive Art (Raccolta selvaggia: un racconto di cannibali, colonialismo e la tragica ricerca di arte primitiva di Michael Rockefeller). Hoffman, scrive sul “Corriere della Sera” Livia Manera che recensisce il libro, “ha imparato la lingua degli Asmat [la tribù cannibale che si sarebbe cibata del misero ricercatore, N.d.R.] e si è recato in quella regione (…) per scoprire la verità. Ha fatto ricerche negli archivi olandesi e passato al setaccio le lettere dei missionari (…)” (MANERA, Il giallo dell’erede Rockefeller). A quanto pare, dalle ricerche del giornalista americano sembra scaturire la conferma all’ipotesi del cannibalismo, descritta nelle lettere di un missionario che parla del ritrovamento del teschio di Michael e di altri suoi resti, fatti poi sparire. “La rivelazione finale di questa triste e truce storia” – continua la Manera – è (…) quella di un insabbiamento da parte delle autorità olandesi. Che, da un lato, stavano per lasciare la Nuova Guinea e avevano interesse a dimostrare di averla resa più civile, debellando il cannibalismo; e che, da un altro, si preoccuparono di non aggiungere ulteriori pene alla famiglia dei Rockefeller”, la quale oggi espone al MoMa, fra gli altri capolavori di arte etnica, anche i rari pezzi che Michael ha mandato per arricchire la già straordinaria collezione del padre, dal 1954, col nome di “The Museum of Indigenous art”, esposta in un edificio accanto alla casa dove Nelson Rockefeller è cresciuto. Dopo la tragedia, Rockefeller cambia nome alla collezione in “Museum of Primitive Art”, e lo dedica alla memoria del figlio. Chiuso nel 1974, le sue collezioni finiscono per essere trasferite al MoMa, diventando l’ala Michael C. Rockefeller.
Il breve, intenso filmato ove Mary Rockefeller Morgan, figlia di Nelson e gemella di Michael, parla delle collezioni fu presentato nel 2014 in occasione della mostra “The Nelson A. Rockefeller Vision: In Pursuit of the Best in the Arts of Africa, Oceania, and the Americas.” (“La visione di Nelson A. Rockefeller: alla ricerca del meglio delle arti in Africa, Oceania e Americhe”).
Mary, oggi ultraottantenne, ha sofferto moltissimo la perdita del fratello; quando scomparve seguì il padre nella sua spedizione per cercarlo, come sappiamo senza successo. Il suo dolore lacerante ha avuto un primo punto fermo nel libro tragico e commovente che scrisse su cosa significhi la morte non solo di un fratello, ma di un gemello. Soprattutto, però, si è sempre occupata, con passione e testardaggine, del museo paterno dove nacque la sua passione di bambino e poi di giovane studioso. Secondo lei l’attrazione di Nelson per l’arte primitiva potrebbe essere stata radicata nella sua dislessia, un disturbo dell’apprendimento che colpisce la capacità di leggere e scrivere, che sia lei sia Michael hanno ereditato. “Con la dislessia si sviluppa un vero senso visivo sul posizionamento degli oggetti”, sostiene Mary, un ordine che si forma nella mente e non è necessariamente qualcosa che riusciamo a vedere anche noi: se il dipinto preferito di Michael era uno stravagante collage di Georges Braque, è una delle leggende di famiglia la volta in cui Nelson, invitato a cena dagli Astor, entrò nel soggiorno di Brooke e senza una parola iniziò a cambiare l’ordine dei mobili secondo uno schema che vedeva solo lui.
Sam Smith, autore di un recentissimo articolo su Rockefeller e il Museo etnografico del Met, pensa che Nelson “abbia visto dei parallelismi tra l’arte indigena e le forme astratte che doveva sempre spiegare ai non iniziati”; a ciò si univano la sua passione per gli affari e per il piacere. Certamente i suoi sentimenti per l’America Latina trovarono espressione nel suo collezionismo così come successe per l’Africa negli anni ‘50, quando la maggior parte degli americani si accontentava di ignorare il continente.
Proprio in quest’ultimo periodo, dopo i vigorosi sforzi di raccolta fondi di Mary e la sua insistenza, sostenuta dai conservatori del museo, la vasta facciata continua di vetro rivolta a sud è stata riaperta dopo la schermatura, necessaria a proteggere gli oggetti vulnerabili dal sole.
La nuova ala, ha detto Mary Morgan, ha rappresentato e continua a rappresentare finalmente la chiusura di un episodio devastante per la famiglia Rockefeller.
“Michael ed io eravamo perduti”, scrive Mary (lui letteralmente, lei figurativamente), ma “la cosa che ci ha permesso di accettare la morte di Michael è che la vita continua davvero in questo dono che ha portato dalla Nuova Guinea”.
Nelson Rockefeller è colui che, alla fine degli anni Cinquanta, importa in Italia il negozio “globale” statunitense, il supermercato, attraverso la società da lui fondata, la IBEC, avente quale scopo il profitto legato a finalità sociali e politiche, portando il benessere di base a tutti i livelli della popolazione iniziando, appunto, da quello dei beni di prima necessità a prezzi accessibili, cosa che avrebbe potuto dimostrare, in piena Guerra Fredda fra Stati Uniti e Unione Sovietica, come anche il capitalismo occidentale fosse in grado di generare benefici per tutti allo stesso modo, e anche di più, delle altre economie. In società con la IBEC entrano fra gli altri i fratelli Caprotti, Guido, Bernardo e, in seguito, Claudio. Con la IBEC nel 1957 aprono a Milano il primo negozio in viale regina Giovanna, il “Supermarket”; e quando, a metà degli anni Sessanta, gli americani si ritirano per portare il progetto supermarkets in altri Paesi del mondo i Caprotti, rimasti unici proprietari, faranno della “Supermarket” l’ “Esselunga”, il più antico e allo stesso tempo più moderno supermercato del Paese. (G. CAPROTTI, Le ossa, pp. 47 sgg.).
Fonti:
THEMeT, Nelson A. Rockefeller and His Daughter Mary Morgan on His Collecting
Bibliografia:
Dartmouth, The Nelson A. Rockefeller Center for Public Policy and the Social Sciences, C. JAVENS ’23, (…), Outside the Lines: Nelson A. Rockefeller as Politician and Patron of the Arts.
Rockefeller Archive Center, Arts & Culture/Issues in Philanthropy/Photo Essay/Photo Essay: L. VINK, A Mother, a Son, and Modern Art, July 7, 2020.
C. HOFFMAN, Savage Harvest: A Tale of Cannibals, Colonialism, and Michael Rockefeller’s Tragic Quest for Primitive Art, William Morrow & Co., 2014.
L. MANERA, Il giallo dell’erede Rockefeller. Incidente o atto di cannibalismo?, in “Corriere della Sera”, 30 luglio 2014.
S. ROBERTS, A Young Rockefeller Vanished in 1961. Met’s New Wing Celebrates His Memory, in “New York Times”, 29 maggio 2025; aggiornato il 1 giugno 2025.
Museum of Primitive Art, scheda in WIKIPEDIA, The Free Encyclopedia.