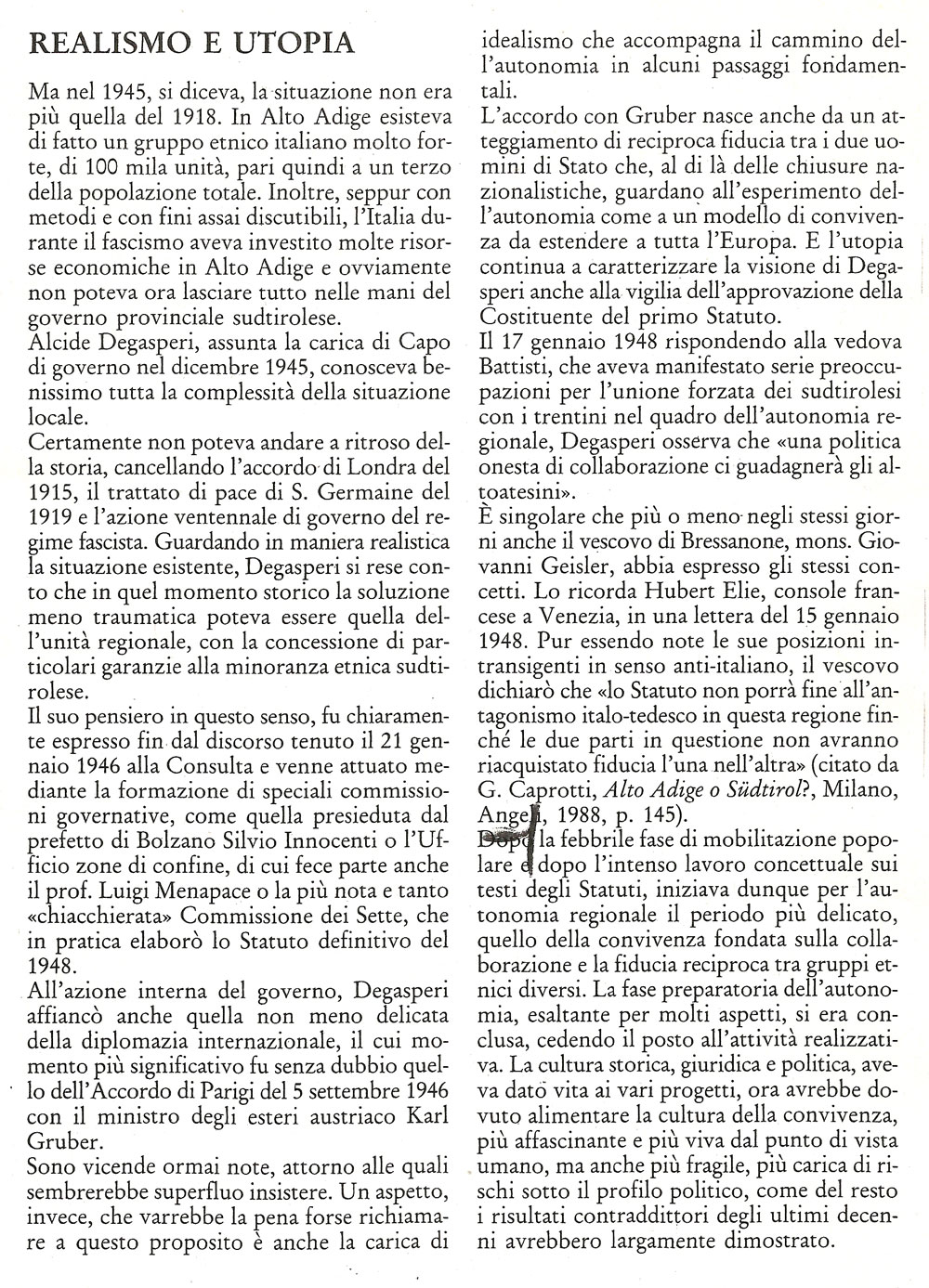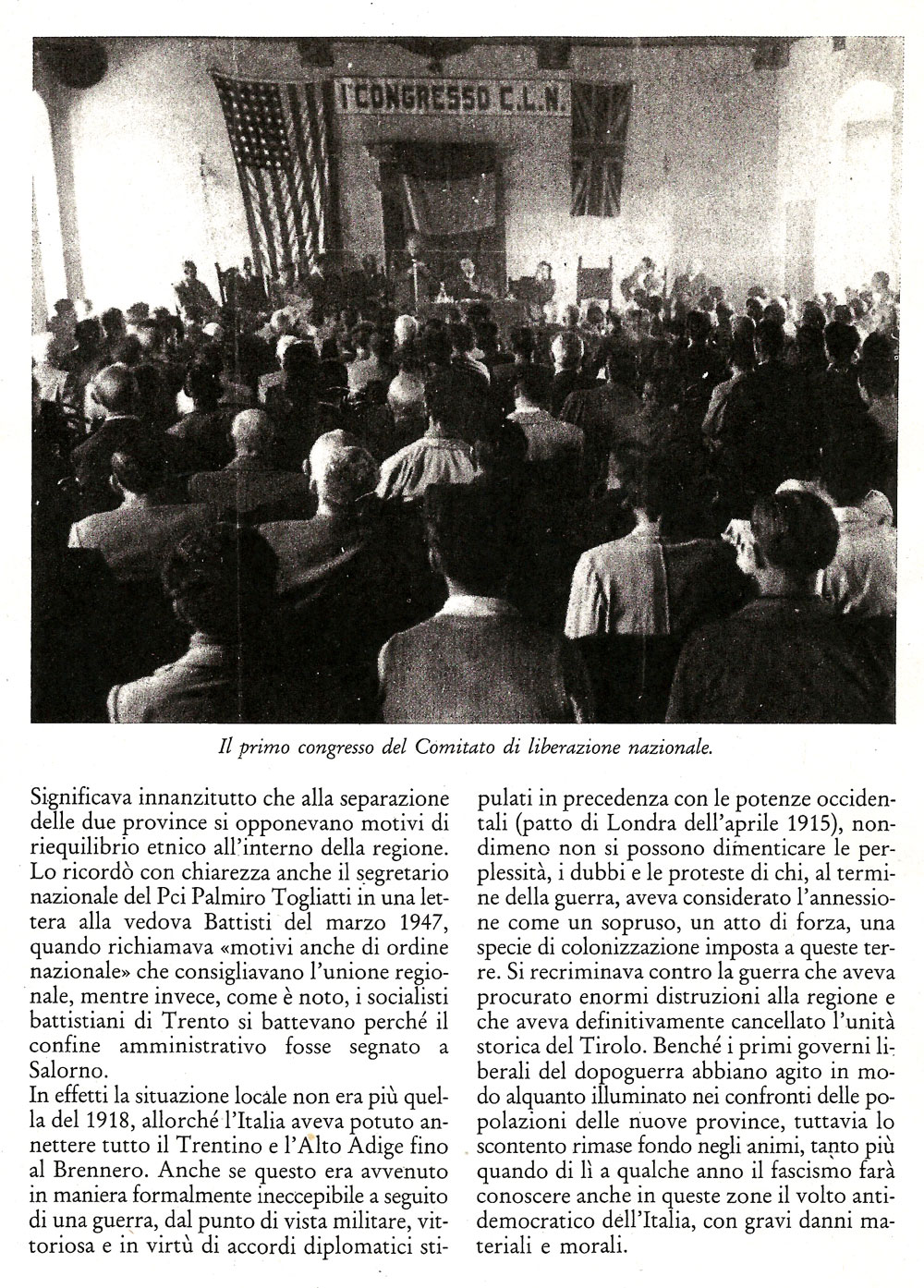“Ma nel 1945, si diceva, la situazione non era più quella del 1918. In Alto Adige esisteva di fatto un gruppo etnico italiano molto forte, di 100 mila unità, pari quindi a un terzo della popolazione totale. Inoltre, seppur con metodi e con fini assai discutibili, l’Italia durante il fascismo aveva investito molte risorse economiche in Alto Adige e ovviamente non poteva ora lasciare tutto nelle mani del governo provinciale sudtirolese. Alcide De Gasperi, assunta la carica di Capo di governo nel dicembre 1945, conosceva benissimo tutta la complessità della situazione locale. Certamente non poteva andare a ritroso della storia, cancellando l’accordo di Londra del 1915, il trattato di pace di S. Germaine del 1919 e l’azione ventennale di governo del regime fascista. Guardando in maniera realistica la situazione esistente, De Gasperi si rese conto che in quel momento storico la soluzione meno traumatica poteva essere quella dell’unità regionale, con la concessione di particolari garanzie alla minoranza etnica sudtirolese. Il suo pensiero in questo senso, fu chiaramente espresso fin dal discorso tenuto il 21 gennaio 1946 alla Consulta e venne attuato mediante la formazione di speciali commissioni governative, come quella presieduta dal prefetto di Bolzano Silvio Innocenti o l’Ufficio zone di confine, di cui fece parte anche il prof. Luigi Menapace o la più nota e tanto «chiacchierata» Commissione dei Sette, che in pratica elaborò lo Statuto definitivo del 1948. All’azione interna del governo, De Gasperi affiancò anche quella non meno delicata della diplomazia internazionale, il cui momento più significativo fu senza dubbio quello dell’Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 con il ministro degli esteri austriaco Karl Gruber. Sono vicende ormai note, attorno alle quali sembrerebbe superfluo insistere. Un aspetto, invece, che varrebbe la pena forse richiamare a questo proposito è anche la carica di idealismo che accompagna il cammino dell’autonomia in alcuni passaggi fondamentali. L’accordo con Gruber nasce anche da un atteggiamento di reciproca fiducia tra i due uomini di Stato che, al di là delle chiusure nazionalistiche, guardano all’esperimento dell’autonomia come a un modello di convivenza da estendere a tutta l’Europa. E l’utopia continua a caratterizzare la visione di De Gasperi anche alla vigilia dell’approvazione della Costituente del primo Statuto. Il 17 gennaio 1948 rispondendo alla vedova Battisti, che aveva manifestato serie preoccupazioni per l’unione forzata dei sudtirolesi con i trentini nel quadro dell’autonomia regionale, De Gasperi osserva che «una politica onesta di collaborazione ci guadagnerà gli altoatesini». È singolare che più o meno negli stessi giorni anche il vescovo di Bressanone, mons. Giovanni Geisler, abbia espresso gli stessi concetti. Lo ricorda Hubert Elie, console francese a Venezia, in una lettera del 15 gennaio 1948. Pur essendo note le sue posizioni intransigenti in senso anti-italiano, il vescovo dichiarò che «lo Statuto non porrà fine all’antagonismo italo-tedesco in questa regione finché le due parti in questione non avranno riacquistato fiducia l’una nell’altra» (citato da G. Caprotti, Alto Adige o Südtirol?, Milano, Angeli, 1988, p. 145).
Dopo la febbrile fase di mobilitazione popolare e dopo l’intenso lavoro concettuale sui testi degli Statuti, iniziava dunque per l’autonomia regionale il periodo più delicato, quello della convivenza fondata sulla collaborazione e la fiducia reciproca tra gruppi etnici diversi. La fase preparatoria dell’autonomia, esaltante per molti aspetti, si era conclusa, cedendo il posto all’attività realizzativa. La cultura storica, giuridica e politica, aveva dato vita ai vari progetti, ora avrebbe dovuto alimentare la cultura della convivenza, più affascinante e più viva dal punto di vista umano, ma anche più fragile, più carica di rischi sotto il profilo politico, come del resto i risultati contraddittori degli ultimi decenni avrebbero largamente dimostrato.
Significava innanzitutto che alla separazione delle due province si opponevano motivi di riequilibrio etnico all’interno della regione. Lo ricordò con chiarezza anche il segretario nazionale del Pci Palmiro Togliatti in una lettera alla vedova Battisti del marzo 1947, quando richiamava «motivi anche di ordine nazionale» che consigliavano l’unione regionale, mentre invece, come è noto, i socialisti battistiani di Trento si battevano perché il confine amministrativo fosse segnato a Salorno. In effetti la situazione locale non era più quella del 1918, allorché l’Italia aveva potuto annettere tutto il Trentino e l’Alto Adige fino al Brennero. Anche se questo era avvenuto in maniera formalmente ineccepibile a seguito di una guerra, dal punto di vista militare, vittoriosa e in virtù di accordi diplomatici stipulati in precedenza con le potenze occidentali (patto di Londra dell’aprile 1915), nondimeno non si possono dimenticare le perplessità, i dubbi e le proteste di chi, al termine della guerra, aveva considerato l’annessione come un sopruso, un atto di forza, una specie di colonizzazione imposta a queste terre. Si recriminava contro la guerra che aveva procurato enormi distruzioni alla regione e che aveva definitivamente cancellato l’unità storica del Tirolo. Benché i primi governi liberali del dopoguerra abbiano agito in modo alquanto illuminato nei confronti delle popolazioni delle nuove province, tuttavia lo scontento rimase fondo negli animi, tanto più quando di lì a qualche anno il fascismo farà conoscere anche in queste zone il volto antidemocratico dell’Italia, con gravi danni materiali e morali.“
Il Trentino – Febbraio 1989