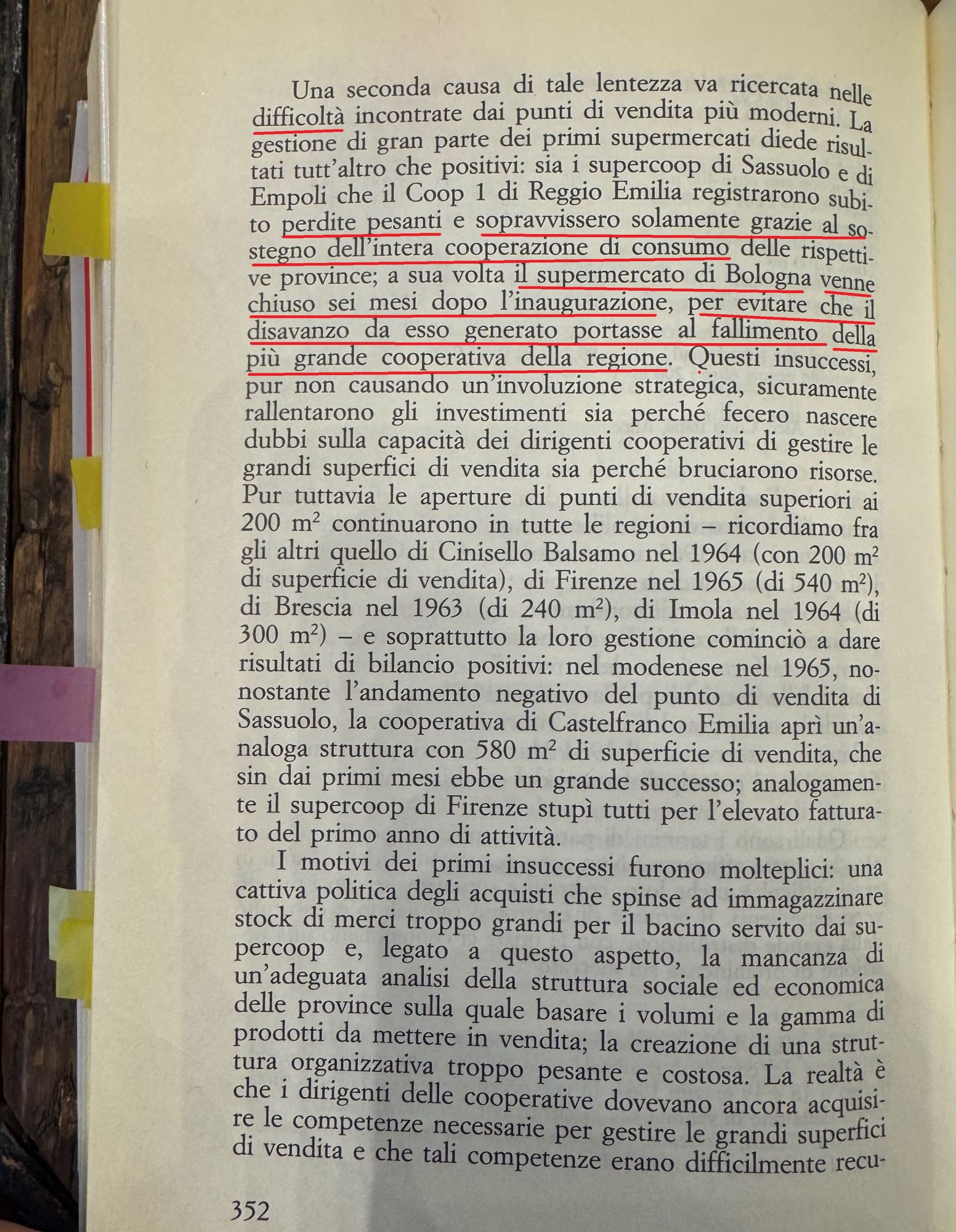A seguito del mio libro “Le ossa dei Caprotti” sono spuntati tanti “divulgatori” della storia di Esselunga, di quella della Coop e del ruolo che la Cia avrebbe avuto nel secondo dopoguerra.
Peccato che, molto spesso, il loro racconto non abbia fonti certe.
17 febbraio 2024
La guerra fredda dei supermercati: quando la CIA combatteva le Coop
La Guerra Fredda è uno dei protagonisti ricorrenti di questi editoriali, sopratutto la guerra tra spie e tra i due principali Servizi di Intelligence della Storia, la CIA e il KGB.
Questo perché chi scrive è fermamente convinto che la maggior parte dei cosiddetti “misteri italiani” in realtà non ha nulla di misterioso ma è proprio frutto di quella contrapposizione tra Servizi che fu la vera guerra fredda, combattuta prevalentemente proprio qui nel nostro Paese.
E dato che non ci si poteva scontare in campo aperto, la guerra tra spie divenne sempre più ideologica e strategica, invadendo ogni campo della società, perfino quello alimentare.
Ebbene si, anche la concorrenza tra supermercati fu oggetto di scontro tra USA e URSS.
Il Cooperativismo in Italia nasce nella seconda metà dell’ 800 in ambito socialista e cattolico, scindendosi progressivamente in Cooperative di consumo rispettivamente “rosse” e “bianche”, ma sarà quello “rosso” a conoscere dal 1947 uno sviluppo straordinario fino alla realizzazione dei giganteschi ipermercati degli anni ‘90, che di fatto sono andati ben oltre lo spirito cooperativo iniziale e hanno spostato appieno il sistema dell iperconsumismo globale.
Delle e sulle “Cooperative Rosse” è stato detto di tutto, nel bene e nel male, dai rapporti con le amministrazioni locali fino ai presunti finanziamenti sovietici che ne avrebbero favorito lo sviluppo su scala nazionale: Bernardo Caprotti, patron di Esselunga, diede alle stampe ‘Falce e Carrello”, un libro che fu un vero e proprio Best seller e che accusava le Coop Rosse di ogni genere di scorrettezze.
Caprotti fu un vero e proprio simbolo dell’anticomunismo italiano, e il suo gruppo fu il più acerrimo nemico delle grandi Coop Rosse, un vero e proprio baluardo atlantico i cui soci di maggioranza erano nientemeno che i Rockefeller con la loro IBEC, gigante globale dei supermarket mondiali made in USA.
Ma proprio all’origine di Esselunga c’è lo zampino della CIA. I Caprotti erano ricchi tessutai, e fu grazie all’amico imprenditore Brunelli che a metà anni ’50 decisero di investire nel nuovo business dei supermercati. A proporre loro l’affare fu James Hugh Angleton, il direttore italiano della NCR, multinazionale americana dei registratori di cassa, che abitava a Milano fin dagli anni ’30 in Corso Venezia dove conobbe il Brunelli [Marco Brunelli]
Ebbene dopo la Guerra ebbe il compito di selezionare su mandato dei Rockefeller imprenditori italiani affidabili e sicura fede anticomunista da far soci nella “colonizzazione” alimentare che sarebbe stato il carburante del boom economico italiano.
Angleton, ufficiale decorato dell’esercito americano, era nientemeno che il padre di James Jesus Angleton, il braccio destro del Generale Donovan fondatore di quella OSS da cui poi nascerà la CIA: Angleton Jr sarà il capo della stazione CIA in Italia, fino a diventare il capo del controspionaggio mondiale americano e il numero due della CIA per oltre 29 anni, uno degli uomini più potenti del mondo cui si deve la nascita dei Sevizi Segreti italiani ad opera dal prefetto Federico Umberto D’amato, che di Angleton fu per anni il pupillo.
La cosa in realtà non deve stupire più di tanto: anzitutto ai suoi albori la CIA selezionava i propri agenti tra le famiglie più ricche bianche e protestanti, in modo che non fossero facili da comprare e di sicura fede americana familiare.
E nemmeno devono stupire i rapporti stretti tra CIA e grandi multinazionali americane: Allen Dulles, il più potente direttore della CIA , era il fratello del grande capo della United Fruit Company Americana, per favorire i cui interessi in Guatemala la CIA del fratello arrivò perfino al colpo di Stato.
Angleton lasciò la CIA alla fine degli anni 70, e gli è stato dedicato perfino un film da Robert De Niro, The Good Shepherd, mentre Bernardo Caprotti con una straordinaria capacità imprenditoriale rilevò la maggioranza delle azioni dai Rockefeller divenendo il re dei supermercati italiani.
Francesco Martelli
Sovrintendente agli Archivi del Comune di Milano
Docente di archivistica all’Università degli studi di Milano
“La concorrenza tra supermercati fu oggetto di scontro tra USA e URSS”?
I supermercati sono stati inventati dagli americani, l’Unione Sovietica, all’epoca, non aveva la più pallida idea di cosa fosse un supermarket.
Oltre al ruolo aziendale e sociale era anche un’entità molto politicizzata . Rockefeller infatti pensava che fosse “difficile essere comunista con la pancia piena” (“it’s hard to be a Communist with a full belly.”
Ma i supermercati Coop nacquero sei anni dopo l’Esselunga , quando gli americani stavano già per lasciare l’Italia, cosa che fecero definitivamente nel 1965.
Dal testo che segue – tratto da “La cooperazione di consumo in Italia”, Il Mulino, 2004, si capisce perfettamente che, quando le cooperative decisero di lanciarsi nel campo dei supermercati difettavano del tratto distintivo che aveva portato al successo l’Esselunga degli albori : il management.
I manager americani dell’Esselunga si chiamavano Richard Boogart, Dick Simpson, Roland Hood, Wayne Broehl e Duane Horney. Ne ho parlato abbondantemente nel mio libro, “Le ossa dei Caprotti”.
E le cooperative , che si lanciarono da sole – senza capitali e suggerimenti dall’URSS – nel campo dei supermercati rischiarono il fallimento.
Sull’approccio ai fatti storici puoi leggere anche : “Le ossa dei Caprotti” : la differenza tra cronaca giornalistica e storia.
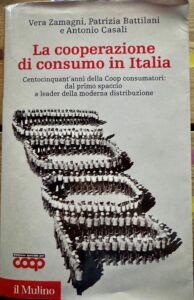
pagina 350
La prima realizzazione concreta fu nel 1957 l’inaugurazione da parte della Cooperativo di consumo del popolo di Bologna da di uno spaccio senza commessi: il primo negozio self-service del movimento italiano al quale ne sarebbero seguiti molti altri.
La seconda tappa fondamentale fu l’inaugurazione dei primi supercoop, cioè i primi grandi supermercati del movimento cooperativo, nel 1963: il Coop 1 di Reggio Emilia (oltre 2.000 m2 di superficie di vendita organizzato su due piani collegati da scale mobili) e i supermercati di Empoli, di Sassuolo (di 800 m2) e di Bologna.
Nonostante questi coraggiosi tentativi, l’opera di modernizzazione procedette molto lentamente…. i negozi tradizionali restarono l’ossatura della cooperazione di consumo per tutti gli anni Sessanta e solamente nel decennio successivo i punti di vendita superiori ai 200 m2 e soprattutto quelli con oltre 400 m2 divennero una percentuale importante della rete di vendita e soprattutto del fatturato.
Le ragioni di tale lentezza furono molteplici. In primo luogo il tatto che, nonostante le scelte di alcuni dirigenti particolarmente lungimiranti, nell’insieme i movimento del consumo impiegò molto tempo a sposare una strategia incentrata sull’innovazione. Ricordiamo che il I Congresso dell’Ancc del 1958 se da una parte indicava l’obiettivo di un rinnovamento delle attrezzature tradizionali di distribuzione e la loro sostituzione con impianti razionali e moderni, dall’altra sottolineava che tali investimenti non implicavano automaticamente l’introduzione del self-service (53)
In realtà fu solamente verso la metà degli anni Sessanta a partire dal convegno di Cortina del…
Quali sono i termini di paragone sui quali possiamo misurare la nostra efficienza? Non sono certamente i dettaglianti, in gravi difficoltà anche loro, costretti a sopravvivere con i più diversi espedienti. Il termine di confronto più valido è costituito calla grande distribuzione con la quale ci contendiamo una posizione di preminenza sul mercato (53).
- Il primo spaccio self service del movimento italiano, in «La Cooperazione italiana», 17 luglio 1957. Per l’Emilia-Romagna ricordiamo Vignola in provincia di Modena, Lugo e Massalombarda nel Ravennate edi P. Catellani, Uno spaccio attrezzato a self service inaugurato, Salla coperativa di consumo di Vignola, ivi, 9 Ottobre 1957. C. Folli, sistema self service comincia a penetrar nel ravennate, ivi, 23 ottobre 1957.
- Ancc, Relazione introduttiva, I Congresso, 1958.
Pagina 351
1964 che l’adozione delle moderne tecniche di vendita divenne l’obiettivo di tutto il movimento (54). Tale scelta fu poi confermata nel 1965 in occasione del IIII Congresso del-l’Ancc, il quale indicò come pilastro della riorganizzazione della cooperazione di consumo e, aggiungiamo noi, del superamento della crisi che da molti anni l’attanagliava, proprio la trasformazione della rete di vendita con l’utilizza-zione delle tecniche più avanzate: l’innovazione diventava quindi la strategia dell’intero movimento. Come molto lucidamente osservava nel 1964 Mario Cesari, presidente dell’Aicc e tra i principali fautori del cambiamento:
- Le prime basi concrete furono gettate a Cortina d’Ampezzo, in occasione del convegno nazionale sulla politica commerciale che ebbe luogo il 18 e 19 giugno 1964. In tale occasione si legò la modernizzazione della rete di vendita alla localizzazione dei nuovi spacci.
- M. Cesari, Relazione, Convegno nazionale sulla politica commerciale, 18 e 19 giugno 1964…, cit.
pagina 352
Una seconda causa di tale lentezza va ricercata nelle difficoltà incontrate dai punti di vendita più moderni. La gestione di gran parte dei primi supermercati diede risultati tutt’altro che positivi: sia i supercoop di Sassuolo e di Empoli che il Coop 1 di Reggio Emilia registrarono subito perdite pesanti e sopravvissero solamente grazie al sostegno dell’intera cooperazione di consumo delle rispettive province; a sua volta il supermercato di Bologna venne chiuso sei mesi dopo l’inaugurazione, per evitare che il disavanzo da esso generato portasse al fallimento della più grande cooperativa della regione. Questi insuccessi, pur non causando un’involuzione strategica, sicuramente rallentarono gli investimenti sia perché fecero nascere dubbi sulla capacità dei dirigenti cooperativi di gestire le grandi superfici di vendita sia perché bruciarono risorse.
Pur tuttavia le aperture di punti di vendita superiori ai 200 m2 continuarono in tutte le regioni – ricordiamo fra gli altri quello di Cinisello Balsamo nel 1964 (con 200 m2 di superticie di vendita), di Firenze nel 1965 (di 540 m2), di Brescia nel 1963 (di 240 m2), di Imola nel 1964 (di 300 m2) – e soprattutto la loro gestione cominciò a dare risultati di bilancio positivi: nel modenese nel 1965, nonostante l’andamento negativo del punto di vendita di Sassuolo, la cooperativa di Castelfranco Emilia aprì un’analoga struttura con 580 m2 di superficie di vendita, che sin dai primi mesi ebbe un grande successo; analogamente il supercoop di Firenze stupì tutti per l’elevato fatturato del primo anno di attività.
I motivi dei primi insuccessi furono molteplici: una cattiva politica degli acquisti che spinse ad immagazzinare stock di merci troppo grandi per il bacino servito dal supercoop e, legato a questo aspetto, la mancanza di un’adeguata analisi della struttura sociale ed economica delle province sulla quale basare i volumi e la gamma di prodotti da mettere in vendita; la creazione di una struttura organizzativa troppo pesante e costosa. La realtà è che i dirigenti delle cooperative dovevano ancora acquisire le competenze necessarie per gestire le grandi superfici di vendita e che tali competenze erano difficilmente recu =
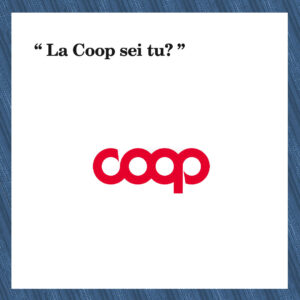
Pagina 353
perabili sul mercato: sia il Coop 1 di Reggio Emilia sia il supermercato di Sassuolo assunsero manager che si erano formati nelle maggiori catene private (leggi Standa), senza ottenere risulati positivi. Non a caso la Supermarkets Italiani [Esselunga] venne gestita nei primi anni di attività da un management interamente americano e che aveva alle spalle alcuni decenni di esperienza nel settore. Non restava quindi che imparare dagli errori fatti e lasciar maturare una nuova leva di dirigenti cooperativi.
La scelta di razionalizzare il movimento per migliorarne l’efficienza pose anche il problema dei circoli e dei bar cooperativi che avevano sempre fatto parte del movimento del consumo e spesso erano stati gestiti unitariamente alle cooperative. La separazione fra bar e negozi in molte province era stata adottata autonomamente durante gli anni Sessanta. Comunque il congresso dell’Ancc del 1970 sancì in modo definitivo tale separazione, allo scopo di salvaguardare da un lato l’efficienza economica dei negozi, ma dall’altro anche per lasciare tutto lo spazio che era giusto riconoscere alla funzione ricreativa e culturale dei circoli.
Il circolo cooperativo deve essere in grado di cogliere e di suscitare i diversi interessi culturali, ricreativi per l’impiego del tempo libero dei lavoratori, delle donne, dei giovani I…] deve essere un punto importante di vita associativa democratica collegato ai problemi e agli interessi sociali e culturali della comunità in cui opera […] Tale linea impone in primo luogo che la gestione dei circoli cooperativi venga resa autonoma, quindi staccata dalla gestione delle cooperative di consumo (56).
Questa decisione per alcuni aspetti marginali evidenziava ancor più come il Movimento avesse deciso di puntare sulla specializzazione in un unico settore: quello della distribuzione commerciale e in particolare sulle grandi superfici di vendita.
- Ance, Relazione introduttiva, IV Congresso, 1970, pp. 38-39.
Sotto: pagina tratta da “La cooperazione di consumo in Italia”, Il Mulino, 2004. la prefazione del libro è a cura di Aldo Soldi e Vincenzo Tassinari.